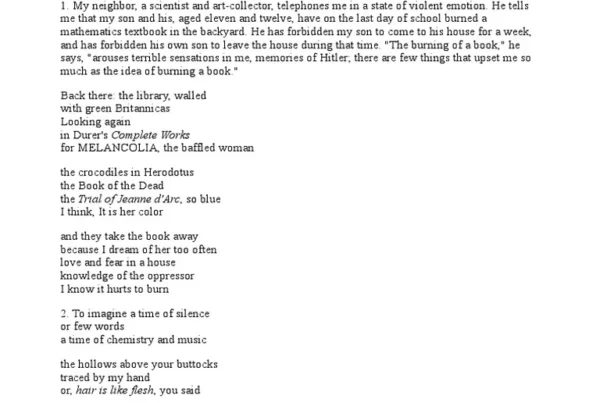P-r-i-d-e, 54 anni dopo la rivolta dello Stonewall Inn a giugno si celebra il mese dell’orgoglio Lgbtqia+. Orgogliosə e incazzatə è una serie di quattro articoli che ci accompagnerà per tutto il mese di giugno raccontando storie, narrando battaglie e indicando una realtà che, al netto di un indubitabile miglioramento progressivo, rimane aperta e da conquistarsi.
di Giuseppe Pepe

Ho visto molte volte foto di persone che hanno subito un’aggressione solo perché omosessuali: facce tumefatte, lividi, ematomi, ferite aperte, sangue, tutte manifestazioni di una violenza immotivata, in grado di far inorridire chiunque. Immagini che spesso, nella nostra quotidianità, riteniamo lontane dalla vita di ogni giorno. E quando si presentano di fronte a noi ci sembrano fatti comunque distanti, quasi di un altro mondo, ma succedono costantemente e a volte le ferite più difficili da guarire sono quelle che non sono visibili.
“Siamo stati aggrediti”. E’ questo il pensiero che mi rimbombava nella testa, una constatazione forte, quasi in contrasto al silenzio che ci aveva avvolto subito dopo essere stati lasciati soli da chi, fino a poco tempo prima, ci aveva definiti “gay di merda”. Erano le 23.00 di un giorno settimanale, eravamo seduti sulla panchina del parco dopo aver cenato in un pub. Una scena abituale, forse quasi da film o forse no per la mancanza di elementi notevoli, una brezza serale muoveva le foglie, qualche discussione in lontananza, rotta da qualche risa, a volte il verso di qualche uccello disturbato dai lampioni a led di una Milano dormiente. Una serata normale, ma per chi ci stava raggiungendo in bicicletta due ragazzi che si baciano non sono normali. Prima qualche domanda generica di circostanza, poi il cambio di tono: “ma cosa state facendo qui?” detto in modo indagatorio, “perchè state così vicini?”ora in tono inquisitorio, “siete per caso gay?”. Quest’ultima domanda penso sia una di quelle su cui qualsiasi ragazzo omosessuale ha almeno una volta nella vita tentennato. Ma io non avevo nulla di cui preoccuparmi, come scrivevo all’inizio le immagini di aggressione che a volte vediamo ci sembrano molto distanti. Guardai il ragazzo che stava con me seduto al mio fianco, lo sguardo era preoccupato, lo vedevo, me lo ricordo ancora, ma ci avevano visti baciare mentre si avvicinavano in bicicletta. Perchè mentire? Era giusto mentire? Era giusto dire quello che non eravamo? Nella mia mente si stava formando un pensiero sempre più netto, la preoccupazione di quel momento si sarebbe trasformata in vergogna se non avessi risposto nell’unico modo in cui potevo e dovevo rispondere: “Sì”.
Il tono della mia voce era fiero, forse eccessivamente, ma serviva per nascondere il timore di rispondere che ero gay a degli sconosciuti e, speravo, ero certo potesse cancellare una parte della preoccupazione che si celava dietro gli occhi del ragazzo a cui ora stringevo la mano. Proprio in quel momento, forse perché vinti da quella paura, in modo impercettibile, ci allontanammo, lasciandoci dall’abbraccio delle mani.
“Voi non potete stare qui, due uomini non possono baciarsi in pubblico”. Quello fu l’inizio, il resto furono una serie di azioni e di minacce. Prima qualche calcio mentre ero ancora seduto, poi io che mi frappongo tra il ragazzo con cui mi stavo frequentando e i nostri aggressori, ancora qualche calcio, degli spintoni e infine il loro ordine di andarmene. Ma io non me ne vado proprio da nessuna parte. Mi giro verso il mio ragazzo, aveva una faccia funerea, pallidissima e immagino la dovessi avere anche io. “Io resto qui, non vado da nessuna parte”, ancora qualche calcio e qualche spinta, ma non cado a terra, non voglio cadere a terra. Qualche istante ancora, cercano di prendermi lo zaino ma lo tiro verso di me, qualche momento di stallo, la minaccia di tirare fuori un coltello, ma doveva essere un bluff, infatti non si vide. Si rimisero in bicicletta. “Ritorniamo e se siete ancora qui non sarete così fortunati”. Mentre guardavo allontanarsi le due bici nel buio, sentii qualche singhiozzo di fianco a me. Mi girai. Era il mio ragazzo che non appena si vide di fronte a me incominciò a piangere liberandosi di tutto quello che aveva tenuto dentro negli istanti precedenti, dalla paura alla rabbia. Lo abbracciai ma il pianto si fece più forte e anche io piansi.
Ci sedemmo sulla stessa panchina in silenzio. “Siamo stati aggrediti”, questo era il pensiero che continuava a rimbombare nella testa e intorno a noi la quiete, come se non fosse successo nulla.
Dopo l’aggressione furono molti i pensieri. Ci eravamo allontanati dalla panchina, ci sembrava la cosa più giusta da fare. Mentre camminavamo rimanevamo in silenzio, ma la mia testa era in tumulto. Le considerazioni si affollavano e si intrecciavano: quello che era successo si avviluppava a quello che avremmo dovuto fare o a quello che avremmo potuto fare, in un continuo ballo, o forse sarebbe meglio dire sommossa, tra pensieri sul passato e propositi sull’immediato futuro. Il primo pensiero fu che non era andata poi così male, che ad altri era successo di peggio, che in fin dei conti a parte qualche dolore alle gambe non erano rimasti segnali visibili di quello che era successo. Pensai, e ancora mi meraviglio oggi di ciò, che in fin dei conti il fatto era normale: stavamo in un parco, la sera, due ragazzi, i baci, come potevo aspettarmi che non potesse succedere nulla? Mi accorsi di quelle considerazioni e me ne vergognai. Come potevo pensare che tutto ciò fosse normale? Ed era andata bene? Cosa mai poteva avermi portato a pensare che era andata bene? Di lì a un attimo tutti questi pensieri arrivarono a un’unica conclusione: “Dobbiamo fare una denuncia”. Non mi ricordo se lo dissi riferendosi al mio ragazzo, oppure se all’inizio fu un pensiero in bilico tra la mente e le labbra, ma comunque lo ripetei chiaramente “Penso che dobbiamo fare denuncia su quello che è successo”.
Passarono due giorni. Il mio ragazzo non era convinto che bisognasse andare a denunciare, o comunque era in dubbio. Io più passavano le ore, più ero convinto che si doveva fare. Tante volte ho sentito persone dire che i casi di omofobia non erano in fin dei conti tanti, almeno guardando i numeri riportati dalle questure rispetto alle aggressioni, e mi sarei sentito in qualche modo complice di quella distorsione della realtà se non fossi andato a denunciare. Non potevo permettermelo.
Spiegai questo pensiero al mio ragazzo, era ancora titubante e rispettavo questo suo dubbio. Non mi sarei mosso da solo, non sarebbe stato corretto nei confronti suoi e di quello che avevamo vissuto, che avevamo subito insieme.
Mentre studiavo al Politecnico mi arrivò a un certo punto una sua telefonata. “Mi sono convinto, è la cosa giusta da fare, dobbiamo andare”. Non so se felicità sia il termine più corretto visto ciò che era successo, ma in quel momento fui felice di quella scelta. Guardai subito il luogo della caserma più vicina per sporgere denuncia, ma subito mi prese un dubbio: quale poteva essere l’atteggiamento delle forze dell’ordine rispetto a una denuncia di questo genere? C’era il rischio che venisse sminuito? E nel caso come avrei dovuto reagire?
La paura di rimanere solo, l’ansia di non riuscire a gridare quanto ritenevo grave quello che mi era successo, di essere sminuito sorse mentre prendevo il mio zaino e mi muovevo verso l’uscita dell’università.
Sono tutti sentori che non mi sarei mai immaginato: l’iniziale parvenza di normalità dietro a un’aggressione, quasi a voler sminuire il mio orientamento sessuale nei confronti della società, il timore di rimanere da solo, di vedere strozzata la mia possibilità di dire quanto era successo.
Decisi di chiamare una mia cara amica e di farmi accompagnare per la denuncia. Volevo farlo non solo per me, ma anche per tutte quelle persone, per tutti quei ragazzi che, presi dai miei stessi dubbi, fanno passare troppo tempo, minimizzando o venendo minimizzati dalla propria famiglia, dai propri amici, dai propri conoscenti. Accade molte volte. Spesso sembra più facile convivere, fare in modo che quelle immagini viste in televisioni ritornino a essere distanti. Ma non è così. Sono drammaticamente vicine a noi e il silenzio non ci permette di affrontarle.
Uscii fuori dall’università, il cielo era ancora luminoso e le persone si affollavano ai tavolini. Le strade erano piene di rumore, di folla, di opera, ma io dovevo raccontare quello che era successo. Mi feci coraggio, inghiottii tutti i timori, i pensieri, le paure che si aggrovigliavano nella testa e andai alla caserma più vicina. Mi aspettava già lì sul posto la mia amica. Dopo qualche istante mi disse: “andiamo? sei pronto?”. Risposi di sì e andai a fare la denuncia.
Non avevo facce tumefatte, lividi, ematomi, ferite aperte, sangue sulla pelle, avevo subito un’aggressione e anche se non ne avevo i segnali sul corpo dovevo occuparmi dei segni che mi erano rimasti dentro. Dovevo fare sapere quello che era successo.
Mi sedetti su una delle sedie della caserma, la mia amica non poté entrare, né il mio ragazzo che ci aveva raggiunti, a causa delle norme sul distanziamento che dalla pandemia erano rimaste ancora. “Ci vogliono 2 orette abbondanti per poter sporgere denuncia” mi disse una poliziotta mentre restavo seduto solo nella sala d’aspetto che mi sembrava sconfinata in quel momento. Avevo un po’ di timore che le mie paure si realizzassero, mi guardai in giro, non c’era nessuno. Fissai di nuovo la mia interlocutrice, feci un accenno di sorriso e dissi “Io resto qui, non vado da nessuna parte”.
Ti è piaciuto questo articolo? Trovi gli altri testi di questa rubrica qui