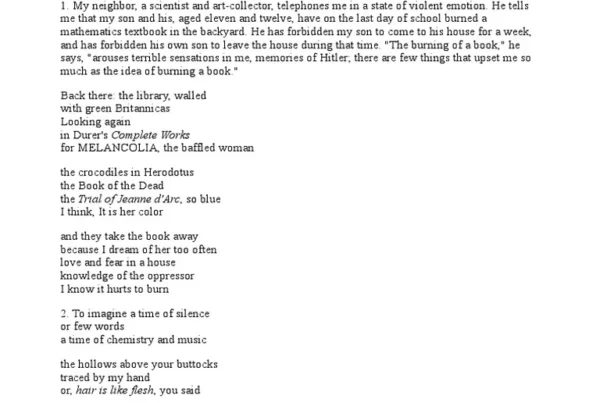di Alessandro Galbiati
YALLA!
L’anno scorso ho fatto un tour in Terra Santa, nulla di così diverso dalla classica vacanza da turista- su-e-giù-dal-pullman, ritmi frenetici che non consentono di cogliere alcuni importanti dettagli.
Eppure, in quei giorni, tra le tante cose viste è stato un luogo a colpire più di altri la mia attenzione: l’Orfanotrofio “La Creche” di Betlemme. Le suore ci avevano accolto dicendoci “Quando volete, venite a darci una mano!”. Detto fatto: quest’anno, con un gruppo di 5 amici, ho deciso di aiutare concretamente una realtà che colpisce al cuore.
La Creche (Che significa La culla) accoglie i bambini dai primi giorni di vita fino ai 6 anni d’età; figli incestuosi, illegittimi: i “più fortunati” vengono abbandonati dalle madri stesse che si presentano per il parto nel vicino ospedale. Alcuni sono trovati nei cassonetti, altri ancora a piangere nella pozza di sangue dei genitori sorpresi e uccisi dai parenti per il loro peccato, come è successo ad Abiba (Amore, in italiano). Alcuni bambini vengono affidati all’Orfanotrofio dai servizi sociali a causa delle condizioni drammatiche in cui versano i genitori. Altri, invece, sono semplicemente rimasti orfani in seguito ai continui conflitti nell’area. Tutti vittime di una cultura. Quale può essere la loro colpa? Ad accoglierci ho visto solo persone in carne ed ossa, tra cui un piccolo cucciolo di 3 giorni appena.
I bambini sono ben consapevoli di non essere voluti e non cercano altro che affetto, o meglio, contatto. Bramano contatto. Ti vedono e si attaccano, senza lasciarti più. Ti baciano, ti picchiano. Conoscono solo l’arabo, i più grandi contano fino a 10 in inglese. Noi non possiamo che adeguarci imparando qualche parola utile per avere a che fare con loro: parole come aiwa (sì), la (no), baden (dopo), entrà o entì (tu), alas (basta) e yalla, l’intercalare maggiormente usato che significa “Dai, forza, coraggio, andiamo”. Parole di cui conosco solo la pronuncia.
Ma cosa facevamo?
Prima di partire avevamo preparato diverse attività da proporre loro: tutto inutile. La realtà di un bambino è più semplice, specialmente quando si vive con poco. Preferiamo perciò improvvisare con quello che ricordiamo della nostra infanzia: l’aeroplano, il cavallino, giocare a rincorrersi… Imparano subito suoni-parole italiane alle quali associano qualche gesto: e quindi via di “La bella lavanderina” e di “Giro giro tondo”!
All’intrattenimento si accompagnavano attività più pratiche: imboccarli, cambio dei pannolini, metterli a letto e, si sa, nessun bambino vuole mai andare a dormire!
Credo che a volte nella vita ci si debba fermare e stare. Stare nei luoghi, negli affetti, nei momenti.
Stare a Betlemme, è stato il modo per conoscerne la cultura e le problematiche.
Ne comprendiamo la complessità già all’aeroporto di Malpensa, dove il personale di sicurezza di El Al, la compagnia di Israele, ci sottopone ad un interrogatorio piuttosto serrato: il volontariato non è ben visto, specialmente se si vuole raggiungere una zona di guerra. Si teme il coinvolgimento in realtà filopalestinesi, si vuole evitare che si vedano cose che devono rimanere nascoste. Siamo costretti a mentire più volte: fingiamo di essere diretti a Gerusalemme Ovest, di essere pellegrini, di volercela spassare a Tel Aviv. A Betlemme, in Cisgiordania, oltre il muro, ci arriviamo di nascosto: l’Occidente è alle spalle, davanti a noi il mondo arabo. Immagini Betlemme e non puoi non pensare ai villaggi del Presepe. Niente di tutto ciò: caos, degrado, puzza, mercati perenni e minareti che richiamano fedeli alla Preghiera a qualsiasi ora del giorno e della notte. Noi siamo minoranza nella minoranza, perché i Cristiani, a Betlemme, sono perlopiù ortodossi. Alcune ragazze del gruppo si sentono a disagio: non portano il velo. Ma anche io mi rendo conto di essere il solo in pantaloncini corti.
Suore a parte, l’impatto con il personale dell’orfanotrofio (inservienti, educatrici, cuoche) è stato impegnativo: non siamo loro simpatici. Si tratta di donne arabe fortunate, perché lavorano, ma temono che le si rubi il mestiere. Ci permettiamo di fare cose che superano il loro modo di intendere la professione, se non la loro cultura: giochiamo insieme ai “reietti”, buttandoci a terra, ridendo e scherzando, facendo versi. Li portiamo in piscina e, rigorosamente coperti, entriamo in acqua con loro: per molti è la prima volta, perciò si va di braccioli, schizzi e lacrime, insieme a tanto divertimento. Ogni tanto ci concediamo qualche passeggiata in Betlemme insieme ai bambini (le inservienti non li portano). Per le strade ci guardano male, pochi sorridono, la polizia quasi ci scorta: “Welcome in Palestine”, precisano. Erano i giorni in cui si celebrava una grande festa musulmana, paragonabile alla nostra Pasqua: la “Festa del Sacrificio”. Grande euforia la sera, impressionante silenzio il mattino. Ma anche i nostri bimbi hanno diritto di vivere una giornata diversa: escono con noi quasi tutti, li portiamo a prendere un gelato da Roni, nostro amico proprietario di un negozio di souvenir accanto alla basilica della Natività. È stato uno dei momenti più belli.
Il rapporto con il personale dell’Orfanatrofio dopo qualche giorno è cominciato a cambiare. Capiscono che siamo lì per dare una mano e non per rubare loro il lavoro, vedono che ci sforziamo ad imparare anche solo poche parole, si rilassano, non ci osservano più con aria perplessa. La seconda settimana ci dicono i loro nomi. E l’ultimo giorno prepariamo del caffè italiano: questa volta è fatta, le abbiamo conquistate! Che sia questa la vera integrazione? Avere consapevolezza della propria cultura e creare le condizioni per un dialogo con le altre.
Stare a Betlemme, significa vedere un muro. Un muro dichiarato illegale dall’ONU. Sentiamo parlare di muri, ma vederlo è bruttissimo. Hai davanti un mostro. E nella sua statica brutalità, il muro è preso d’assalto da artisti o semplici cittadini, disegni che sono opere d’arte, di satira, di denuncia per i torti subiti in attesa di una pace che, ancora oggi, pare un miraggio.
Viviamo sulla nostra stessa pelle cosa significa non avere uno Stato, o meglio, non poter esercitare effettivamente diritti costituzionalmente garantiti. La libertà di movimento è limitata. Le auto con targa palestinese non possono entrare in Israele. Per andare a Gerusalemme (circa 30 minuti di viaggio) prendiamo un pullman, che termina il servizio alle ore 18. Gli spostamenti oltre quell’orario avvengono nella totale incertezza. Al checkpoint i soldati israeliani salgono con il mitra e fanno scendere i palestinesi. Noi, passaporto occidentale, rimaniamo a bordo. Qualcuno attraversa il checkpoint a piedi ma a volte le file sono interminabili a causa di controlli che servono, per lo più, solo a far innervosire le persone e creare tensioni. Le code si snodano per corridoi stretti e inospitali. C’è un clima di rassegnazione. Tante cose sono illegali: dall’Università di Betlemme si scorge nitidamente Har Homa, colonia ebraica. È stata dichiarata, come tante altre, illegale dall’ONU, eppure sta lì, tutelata dal Governo Netanyahu. La strategia è chiara: mangiare il territorio, puntellarlo fino a rendere impossibile l’affermazione di uno Stato Palestinese. Tutto ciò non fa altro che favorire la propaganda estremista di una parte del mondo islamico. Questi insediamenti sono vissuti come uno ostacolo alla pace anche da parte di molti israeliani. I coloni, a loro volta, per la maggior parte fanatici religiosi, si sentono traditi perché vorrebbero essere supportati maggiormente nella loro “missione di avanscoperta”. Lottare per la terra vuol dire esercitare su di essa il controllo. Come rispondono, perciò, i palestinesi? Ampliando le periferie. L’idea è “Costruiamo e, in tal modo, occupiamo, poi si vedrà”.
Il mio intento è solo quello di raccontare qualcosa di oggettivo, senza implicazioni politiche. Molti si schierano per una parte o per l’altra, ma non è mia intenzione rincorrere una causa. Questa esperienza mi ha stimolato diverse riflessioni, contribuendo ad aggrovigliare la matassa, più che sgombrarla. Tante sono le problematiche di questa Terra: religiose, geopolitiche, economiche e di carattere storico. Non mi sento preparato a sufficienza per comprenderle tutte. Più studio, più trovo errori ed ingiustizie da entrambe le parti. Eppure ci viene spesso richiesto di prendere una posizione, a tutti i costi, senza riflettere troppo. Forse, in realtà, la cosa più importante è chiedersi chi, oggi, è oppresso. C’è chi è oppresso dalle proprie paure, perché porta in dote o ha vissuto la sofferenza ed il terrore dello sterminio nazista, c’è chi vorrebbe solo avere una casa finalmente sua, nella “Terra Promessa”. C’è chi è oppresso, invece, perché quella casa se l’è vista ingiustamente togliere o distruggere dai bombardamenti. Chi è povero e lo sarà sempre di più. Chi deve accettare umiliazioni pur di lavorare. Chi è vittima della propria cultura estremista.
E poi ci sono i bambini. Quelli che già pagano per tutto questo.
Torno infine a loro, cercando di rispondere a qualche domanda che forse vi è sorta spontanea leggendo questo mio racconto.
Per l’Autorità palestinese è importante presidiare il territorio anche e soprattutto in termini numerici, ragion per cui i bambini possono essere adottati solo da musulmani. E, tuttavia, sappiamo che per quest’ultimi quelle creature sono un rifiuto.
Dopo i 6 anni devono lasciare l’orfanotrofio, per raggiungere i campi SOS, luoghi dove possono frequentare le scuole. A 18 anni sono finalmente liberi. Già, ma quale libertà? “Liberi” di vagare per le strade, senza una meta. Non hanno diritti, solo cognomi fittizi facilmente riconducibili alla loro condizione di orfani. Ciò li condizionerà per sempre, costringendoli, il più delle volte, ad arrangiarsi vivendo nell’illegalità. È straziante immaginare come alcuni finiranno probabilmente in frange estremiste, dove viene loro promesso di diventare qualcuno, arrivando anche a sacrificarsi in nome della religione, non avendo nulla da perdere e potendo sperare in una vita migliore.
Ultimo giorno, pausa pranzo: per i bimbi è l’ora del riposo. Li portiamo a letto, consapevoli che al loro risveglio non ci troveranno perché saremo già sulla strada per Tel Aviv.
Di alcuni di loro non ho mai saputo il nome. Ma cosa importa? Di ciascuno porto nel cuore il soprannome.
Ciao Karam, Abdo, Priscilla, Adam, Zen, Alà, Piccolo cucciolo di uomo, Marian, Carmela, Adam grande, B’ara, Ramì, ‘Amed, Fratelli rinoceronti, Abiba, Pesciolino…
Yalla!